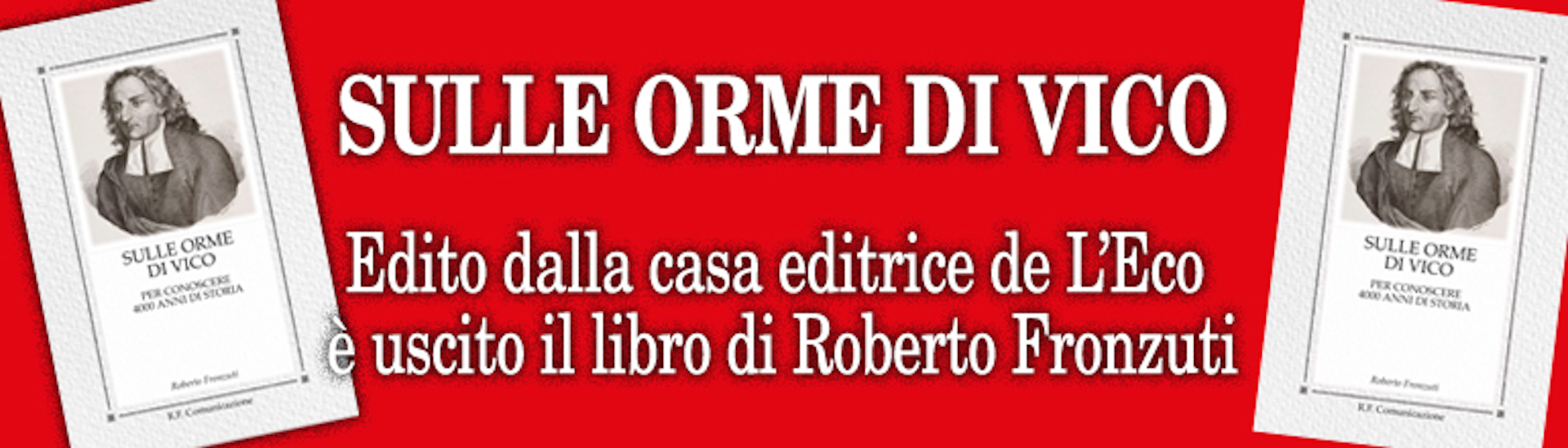L’unica possibilità che abbiamo per evitare il collasso ecologico è puntare su una crescita sostenibile e sulla green economy, grazie anche alle nuove tecnologie.
Conosciamo tutti la locuzione latina “historia magistra vitae”, peccato che nell’epoca attuale la storia venga considerata tra le discipline di studio meno importanti. Le lezioni del passato e delle civiltà scomparse possono esserci invece di grande aiuto, per evitare di commettere gli stessi errori, per capire le sfide del presente e per progettare il nostro futuro.
Anche per quanto riguarda il delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente, assieme al tema dello sfruttamento delle risorse naturali, il passato ci offre ottimi spunti di riflessione per cercare di rispondere ad alcune delle domande più cruciali di sempre. Per esempio è l’uomo a cambiare in maniera decisiva l’ambiente naturale in cui vive, fino a rischiare di mettere a rischio la propria sopravvivenza, o il fattore umano è insignificante nei cambiamenti ambientali e climatici? Qual è il punto massimo di crescita di una civiltà, anche dal punto di vista economico, prima del superamento di una soglia critica che porti a un declino più o meno reversibile?
La storia degli abitanti dell’isola di Pasqua ci può fornire diverse risposte a questi quesiti, in quanto costituisce il caso più vicino a un crollo ecologico “puro” provocato dall’uomo di cui siamo a conoscenza, verificatosi in assenza di fattori esogeni grazie al completo isolamento del luogo. La vicenda è stata descritta nei dettagli, con ricchezza di fonti e dati scientifici, nel libro “Collasso” scritto dal premio Pulitzer Jared Diamond (pubblicato in Italia da Einaudi).
L’isola di Pasqua, lunga appena 11 chilometri da nord a sud, scoperta nel giorno di Pasqua dell’anno 1722 (il 5 aprile) dall’esploratore olandese Jacob Roggeveen, è il luogo abitabile più isolato al mondo. Situata nell’Oceano Pacifico, a est dista 3.700 chilometri dalle coste cilene e, a ovest, 2.100 chilometri dalle isole polinesiane del gruppo di Pitcairn. All’arrivo di Roggeveen l’isola appariva già arida e deserta, ricoperta solo da pochi alberi alti meno di 3 metri e abitata da poche centinaia di autoctoni di origine polinesiana, superstiti di una civiltà ormai da tempo decaduta o, per essere più precisi, collassata. La fonte storica è il diario di Roggeveen stesso. La presenza di numerose e monumentali statue di pietra, i celebri moai, facevano però dedurre agli “alieni” europei che l’isola aveva conosciuto in passato una civiltà più prospera rispetto a quella che si mostrava davanti ai loro occhi. Che cosa era successo su quell’isola prima dell’arrivo degli europei?
Grazie alle ricerche scientifiche sappiamo che in realtà questo luogo, prima dell’arrivo dell’uomo datata intorno al 900 d.C. secondo l’ipotesi più accreditata, era un piccolo paradiso terrestre ricco dal punto di vista della biodiversità. Sia gli alberi che numerose specie autoctone di animali non c’erano più sull’isola all’arrivo di Roggeveen. In mancanza di fattori esterni – arrivo di nemici, influenze di altri popoli o cataclismi naturali – è chiaro che le azioni degli abitanti abbiano giocato un ruolo chiave nella distruzione ambientale dell’isola di Pasqua, a tal punto da portare al collasso la propria civiltà.
È ormai certo che dall’arrivo dei primi polinesiani sull’isola di Pasqua si avviò un lungo processo di disboscamento completo e di esaurimento delle risorse naturali disponibili. Perché?
La società dell’isola di Pasqua, guidata da un capo supremo, era costituita da 11 o 12 clan, ognuno “gestore” di una porzione dell’isola che si estendeva radialmente dalla costa verso l’interno, come le fette di una torta. Ogni zona aveva il suo capo e le proprie piattaforme con le statue per celebrare le cerimonie religiose. I clan facevano a gara a chi avesse le piattaforme e la statue più grandi, innescando una crescita sfrenata di fabbisogno di legname, funi e risorse alimentari per la manodopera. La lotta, da pacifica, divenne però col tempo sempre più agguerrita.
Gli alberi venivano abbattuti per diversi motivi, con un tasso di crescita sempre maggiore man mano che aumentava la popolazione dell’isola. Il legname serviva praticamente per fare tutto: costruire canoe per pescare o navigare in mare aperto, cremare i defunti, riscaldarsi e, cosa fondamentale, a costruire, trasportare ed erigere le colossali statue di pietra, al centro del sistema religioso e politico di questa civiltà. Inoltre, molte aree boschive vennero distrutte per lasciare spazio all’agricoltura.
Si arrivò così, nel giro di qualche secolo, a un punto critico di non ritorno e, al contempo, all’apice di questa civiltà dell’Oceano Pacifico: le risorse naturali non erano più sufficienti a soddisfare una popolazione in continua crescita, che arrivò a superare i 15.000 individui, in un contesto anche competitivo e non cooperativo per la gestione delle risorse. Da qui l’inizio del declino.
La fine della disponibilità di grandi alberi pose fine al trasporto e all’innalzamento delle statue, così come alla costruzione delle canoe per la navigazione in alto mare, precludendo ogni via di fuga alla popolazione in caso di necessità di evacuare l’isola – madrepatria. La deforestazione causò anche una drastica diminuzione delle risorse alimentari, rallentando la produzione agricola che già risentiva di un clima poco adatto, caratterizzato dal vento, dalle piogge e da un terreno poco favorevole alla coltivazione. Nel lungo periodo ci fu un crollo demografico e si diffuse sulla sperduta isola anche il cannibalismo. In breve si era rotto il delicato equilibrio tra ambiente, disponibilità di risorse naturali, presenza dell’uomo e crescita demografica.
Nel 1680, quando il disastro ecologico era ormai in una fase irreversibile, scoppiò una ribellione guidata dai capi guerrieri che mise fine al potere dei sacerdoti, innescando una guerra civile totale per la sopravvivenza. Nel tempo non solo cambiò la dieta alimentare degli abitanti dell’isola, ma anche il sistema dei valori cardini della loro civiltà e soprattutto la religione. Si fermò la costruzione delle statue-totem, che ora, invece, venivano distrutte reciprocamente dai vari clan in lotta tra loro per il dominio dell’isola e delle sue risorse.
Per concludere, subito dopo aver raggiunto l’apice in termini di popolazione e costruzione di statue, a causa della correlata deforestazione che abbiamo visto, la civiltà dell’isola di Pasqua andò verso un triste e inesorabile declino causato da un disastro ambientale autoindotto dall’uomo.
L’isola di Pasqua ci fornisce una lezione importante anche per noi: l’urgenza di uno sviluppo sostenibile per tutti. Grazie alla globalizzazione e alle tecnologie, compreso Internet, tutti gli abitanti della Terra condividono le risorse naturali a disposizione, in competizione tra loro. La Terra è isolata nello spazio tanto quanto l’isola di Pasqua lo è nell’Oceano Pacifico. Non c’è possibilità di emigrare altrove.
A differenza degli abitanti dell’isola di Pasqua però, noi siamo consci da molti anni dei rischi ambientali che stiamo correndo e che abbiamo creato. Abbiamo inoltre conoscenze scientifiche e tecnologiche di cui i popoli del passato non potevano disporre. È importante sfatare il mito della crescita economica illimitata e non controllata, che crea anche grandi diseguaglianze sia tra le nazioni che all’interno di uno stesso paese. Le risorse naturali – acqua, fonti fossili, minerali, piante, animali, etc. – sono limitate e mal distribuite, e non esiste un secondo pianeta abitabile di scorta.
L’unica possibilità che abbiamo per costruire un futuro lontano dal destino degli abitanti dell’isola di Pasqua è puntare su una crescita sostenibile e sulla green economy, grazie anche alle nuove tecnologie. Occorre però essere guidati da una visione del futuro condivisa a livello internazionale, con obiettivi chiari che tengano conto del rispetto dell’ambiente, che è fragile.
Anche nella finanza, oggi più che mai, è eticamente imprescindibile incentivare gli investimenti responsabili (IR), in cui agli obiettivi tipici della gestione finanziaria, cioè l’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento in un dato orizzonte temporale, vengono affiancate considerazioni di natura ambientale, sociale o di governance (fattori denominati ESG – Environmental, Social, Governance).
La pandemia, nonostante il dramma sanitario e le difficoltà economiche che ci sta facendo vivere, ci obbliga a prenderci una pausa forzata dalla frenesia che caratterizzava le nostre vite precedenti, offrendoci una grande opportunità per riprogettare il futuro. Ci ha fatto inoltre scoprire che, se vogliamo, siamo capaci di cambiare i nostri stili di vita, prima che sia troppo tardi.